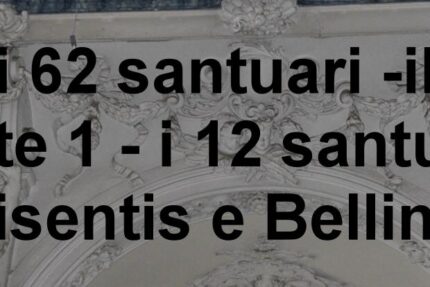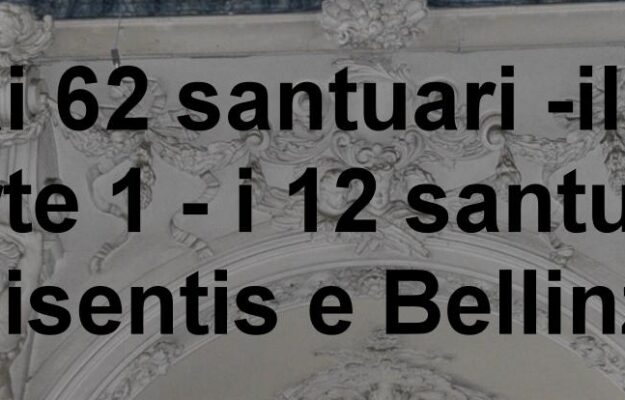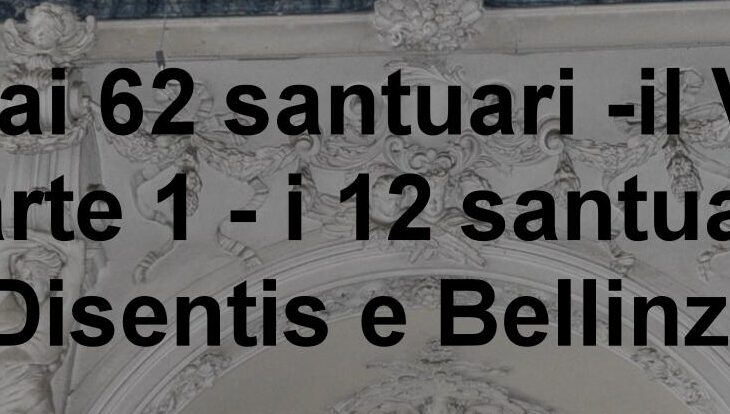29/4/1494 Il Santuario di Re
Il Santuario di Re ha avuto da sempre un forte influsso sulla vita del villaggio e dei paesi limitrofi, tanto da trasformare la piccola Re, un tempo frazione di Folsogno, nell’attuale Re, di cui Folsogno è ora frazione. Arrivando dal confine svizzero il santuario si […]
62 santuari Blog Ossola, Cusio e Novarese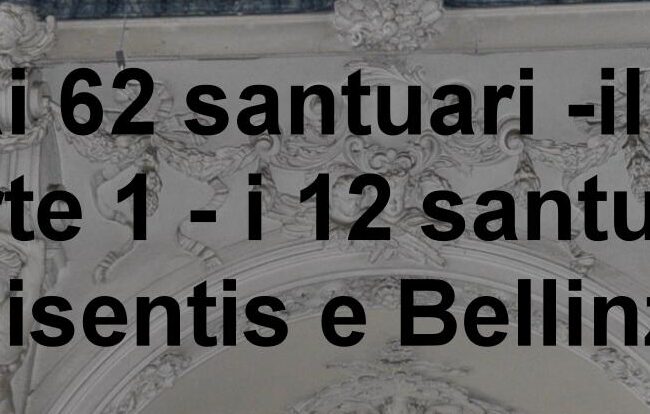
Santuari lungo la Via Francisca, 1: da Disentis a Bellinzona
immagini dei santuari lungo la prima parte della Via Francisca, da Disentis a Bellinzona
62 santuari Blog
La “fabbrica dei Santi” ovvero “le finte reliquie di santi”
A proposito dell’articolo “Putin, Sacro e Profano” pubblicato da “La Stampa” di venerdì 12 gennaio 2024 e poiché nella storia tutto si ripete, ricordo che una vicenda legata a “finte reliquie di santi” e di portata molto maggiore aveva già creato scompiglio nel novarese oltre […]
Blog La Via Francisca Ossola, Cusio e Novarese



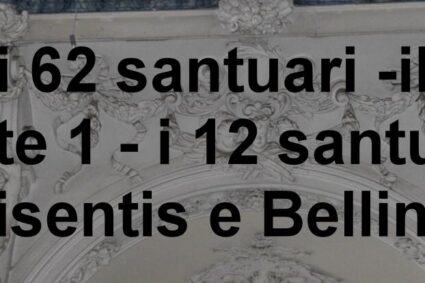
Santuari lungo la Via Francisca, 1: da Disentis a Bellinzona
immagini dei santuari lungo la prima parte della Via Francisca, da Disentis a Bellinzona
62 santuari Blog
29/4/1494 Il Santuario di Re
Il Santuario di Re ha avuto da sempre un forte influsso sulla vita del villaggio e dei paesi limitrofi, tanto da trasformare la piccola Re, un tempo frazione di Folsogno, nell’attuale Re, di cui Folsogno è ora frazione. Arrivando dal confine svizzero il santuario si […]
62 santuari Blog Ossola, Cusio e Novarese
La “fabbrica dei Santi” ovvero “le finte reliquie di santi”
A proposito dell’articolo “Putin, Sacro e Profano” pubblicato da “La Stampa” di venerdì 12 gennaio 2024 e poiché nella storia tutto si ripete, ricordo che una vicenda legata a “finte reliquie di santi” e di portata molto maggiore aveva già creato scompiglio nel novarese oltre […]
Blog La Via Francisca Ossola, Cusio e Novarese

Tracce di Meraviglie: gli affreschi di San Michele, Palagnedra (CH)
Gli affreschi di San Michele di Palagnedra risalgono a fine quattrocento, e mostrano colori e forme vivissimi. Vengono attribuiti ad Antonio da Tradate pittore lombardo che ha operato sia in Ticino che nella vicina Ossola da fine Quattrocento ad inizio Cinquecento. Le opere si trovano […]
La Via Francisca Surselva e Canton Ticino
Il “lago ribelle”, un “lago al contrario”
Il lago d’Orta, il “lago ribelle”, possiede nelle espressioni abituali, una “sponda occidentale” e una “sponda orientale” ma non una “sponda destra” o una “sponda sinistra” come gli altri laghi. La curiosità nasce dalla sua caratteristica unica: quella di avere l’emissario, la Nigoglia, sul lato […]
Blog La Via Francisca Ossola, Cusio e Novarese
La Porta Romana di Omegna
La “Porta Romana” detta anche “Porta della Valle”, perché da qui partiva la via che conduceva in Valle Strona, è in realtà medievale, risalendo al 1100 d.C. Esistevano un tempo ad Omegna ben cinque porte, nelle diverse direzioni, ma le altre quattro sono scomparse. La […]
Blog Ossola, Cusio e Novarese
Pieve Vergonte: “Santa Maria della Posa, forse il santuario più antico”
La chiesa di Santa Maria della Posa era la chiesa parrocchiale di Fomarco, la frazione più antica di Pieve Vergonte, in alto sul monte che sovrasta la valle. La chiesetta, oggi piuttosto sacrificata a causa del muraglione che sostiene la strada, disponeva di un pronao […]
62 santuari Blog Ossola, Cusio e Novarese
Il santuario di Madonna dello Scopello
due santuari, un palio, un antichissimo albero e un nome curioso: Premosello Chiovenda
62 santuari Blog
Santuario Madonna del Bosco, Novara
(da “Guida ai 62 santuari”) Santuario n.ro 59, in occasione della festa, il 10 settembre Questo Santuario di Madonna del Bosco si trova in corso Vercelli a Novara ed è più recente rispetto alla “Madonna del bosco” di Pernate. La storia narra che erano […]
62 santuari Blog